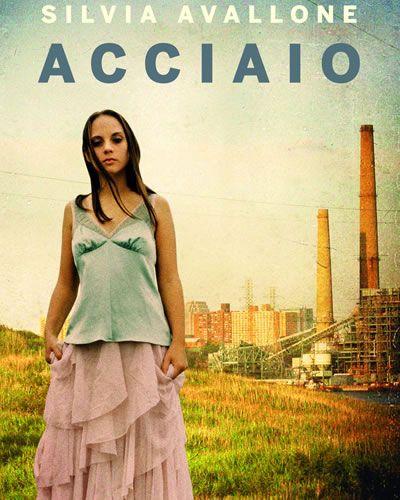L'ARCHIVIO DEGLI ARTICOLI
Gennaio 2017
Ci voleva un comunista
“Adda veni’ baffone” era l’invocazione con la quale il proletariato italiano degli anni cinquanta impetrava la realizzazione di una tra le più fosche (per qualcun altro) e note profezie attribuite a Don Bosco: l’arrivo in Italia dei cosacchi di Stalin, che avrebbero abbeverato i propri cavalli alle fontane di Roma. Ignari dei milioni di morti che il “Piccolo padre” sovietico teneva sulla coscienza, operai e contadini di una Penisola sulla cui pelle bruciavano ancora le ferite e le miserie della guerra, all’epoca ne auspicarono, infatti, la presa del potere perché ritenuta l’ unico lenitivo alle loro disagiate condizioni di vita.
Baffone non è mai arrivato (per fortuna…) e il PCI ha conosciuto l’ebbrezza del potere (quello vero) soltanto nel momento in cui, dopo la caduta dell’URSS, l’allora segretario Achille Occhetto ne decretò la morte e la contestuale resurrezione in salsa socialdemocratica. Ma un comunista è un comunista e rimane tale, nel bene e nel male, anche dopo aver saccheggiato tutto il variegato guardaroba del trasformismo politico. E’ proprio delle ideologie forti marchiare a fuoco (idealmente) i propri adepti, i quali anche se nel tempo mutano opinioni, ammorbidendole o contaminandole, mantengono quasi sempre al fondo un nucleo inscalfibile di orientamenti e visioni della vita su cui nessun cambio di casacca potrà mai incidere.
Confesso che è stato questo il primo pensiero che mi è venuto in mente nel momento in cui, dopo il cambio della guardia al Viminale, il democristiano Alfano ha lasciato il posto al comunista Minniti (uso volutamente questi due disusati aggettivi) e quest’ultimo ha esordito sulla panchina scottante degli Interni ricordandosi e ricordando a tutti che la sicurezza non ha colore politico e che la legge italiana (abito che non si può indossare solo quando ci fa comodo) distingue tra profughi (beneficiari del diritto d’asilo) e migranti economici, i quali ultimi vanno soccorsi (se necessario) e poi rimandati indietro.
Parole sacrosante e abbiamo dovuto aspettare un comunista – dopo anni di ubriacature immigrazioniste senzaseesenzama e una copiosa produzione normativa tesa a non far fare un giorno di detenzione a chi delinque – per sentircelo dire. Ma questo è accaduto perché Minniti è un comunista – comunista, seppur candeggiato in acque laburiste, non un anarco-comunista e tanto meno un catto-comunista, ossia due “categorie dello spirito” che negli ultimi anni hanno fagocitato la gauche italiana occupando tutti i piani dell’edificio progressista, sia a livello di uomini politici che di giornalisti, intellettuali o semplici attivisti. Oggi la sinistra italiana - da quella cd. moderata a quella cd. Antagonista - è una sinistra che sa poco o nulla di Marx e tutto di Don Milani e Papa Francesco. E questo non è normale: Don Milani, la cui grandezza – sia chiaro – nessuno qui vuol mettere in discussione, è pur sempre una emanazione del mondo ecclesiale nella sua più ampia accezione, così come Papa Francesco; Marx, Proudhon e gli altri padri nobili del comunismo e del socialismo internazionali sono un’altra cosa.
Tralasciando il confronto con l’anarchismo libertario, dove le differenze in teoria dovrebbero essere siderali, i punti di contatto, pur numerosi, tra la dottrina sociale della Chiesa o il pauperismo cristiano in genere e il movimento dei lavoratori non sono obiettivamente sufficienti a giustificare la fusione così profonda avvenuta in questi anni tra due realtà che in alcuni settori – come appunto la sicurezza o l’accoglienza – dovevano restare rigorosamente distanti, diverse essendo le responsabilità dell’una (religiose) e dell’altra (politiche) e di conseguenza anche i fini perseguiti: per la Chiesa, un perdonismo (per chi si macchia di reati) che non ammette contropartite o una mistica dell’ ospitalità (verso il pellegrino) che – necessariamente, dal punto di vista della fede - prescinde dalle ragioni (economiche o meno) del peregrinare dell’ospite; per la politica di sinistra, nel primo caso l’emenda inscindibilmente legata al recupero (differenza, questa, sostanziale tra le due declinazioni della sicurezza, quella di destra e quella di sinistra) e nel secondo caso una accoglienza che inevitabilmente non può essere disgiunta dalla sua compatibilità con i numeri, le motivazioni, i comportamenti, la volontà di integrarsi di chi approda nel nostro Paese.
E’ una precisa responsabilità dei gruppi di protesta giovanili post –sessantottini aver innestato nel corpo dei partiti dei lavoratori segmenti di DNA, se non proprio incompatibili, quanto meno in astratto difficilmente conciliabili con la loro natura. Tant’è che il PCI di quegli anni mantenne sempre un atteggiamento profondamente ostile nei loro confronti [1] , così come nei confronti dei piccoli partiti sorti alla sua sinistra, più permeabili agli apporti della cultura cattolica e di quella liberale. Ma dopo il 1989, proprio gli esponenti di quei gruppi e di quei partiti sostituirono lentamente la classe dirigente dell’ormai ex Pci, portando dentro quel partito e dentro la sinistra in genere anche un universo valoriale leggermente diverso, su certe tematiche, da quello nativo delle forze politiche in questione. Il “matrimonio” con i cattolici delle correnti di sinistra della Dc ha fatto il resto.
Risale pertanto a tale fase delle vicende politiche nazionali e internazionali quella deriva neoliberista della socialdemocrazia europea che il PD in Italia ora cerca di celare dietro lo scaltro paravento di un rinnovato vigore sul fronte delle unioni civili (a rigore, un cavallo di battaglia del liberalismo) e di una disponibilità illimitata all’accoglienza dei migranti africani (a rigore, un cavallo di battaglia del volontariato cattolico), in ciò (ma solo in ciò) in pieno accordo con i partiti alla sua sinistra, ormai avvinti come l’edera in un connubio tanto entusiasta quanto poco coerente con radicali e conferenza episcopale.
Ma certe mutazioni genetiche come quelle sfociate, in Italia, con l’approvazione del job act e lo svuotamento dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori (per non parlare della claque appassionata di Confindustria e potentati economico-finanziari dietro ogni peto del governo Renzi), in tandem con gli inevitabili conflitti tra poveri accesi da una gestione esclusivamente emotiva dei fenomeni migratori, sostanzialmente focalizzata solo sulla fase del soccorso umanitario, a lungo andare rischiano di provocare in molte realtà geografiche piccole e grandi del nostro Paese un pericoloso travaso di voti dalla sinistra (radicale o riformista che sia) alla destra lepenista di Salvini, che non a caso sfoggia da tempo opinioni “socialiste” in tema di lavoro e di diritti dei lavoratori (gli attacchi alla legge Fornero, l’adesione ai referendum della CGIL per l’abolizione del job act ecc.), abbinate alla scoperta di una inedita – per la Lega – vocazione nazionale e al sempiterno refrain contro stranieri e malvivenza spicciola (ladri, rapinatori, piccoli spacciatori ecc.).
Infatti, contrariamente a tanti soloni della sinistra culturale e ad altrettanti tromboni di quella politica usi a trascorrere le loro giornate beatamente sdraiati sulle nuvole, Salvini ha capito che una larga fetta di elettori di sinistra desidera con uguale intensità il ripristino dell’art. 18, il contenimento dell’immigrazione (o quanto meno un approccio oculato e attento al problema che tenga conto di molteplici fattori, ad iniziare dalla conoscenza della personalità e delle intenzioni di chi entra nel nostro Paese) e un deciso cambiamento di rotta sul fronte della lotta al degrado, all’ inciviltà e ai reati di cd. allarme sociale come i furti in appartamento; fenomeno questo che ha raggiunto negli ultimi anni dimensioni davvero preoccupanti, con borghi di poche centinaia di anime fino a poco tempo addietro immuni da qualsiasi tipo di criminalità e oggi invece letteralmente assediati da bande organizzate di malfattori (italiani e stranieri) che “visitano” puntualmente e talvolta ripetutamente le loro case, certi della sostanziale impunità delle proprie condotte, visto che per i giudici ripulire un appartamento e far precipitare nel dramma famiglie che magari con grande fatica l’avevano arredato, non è un illecito penale meritevole d’attenzione e di risposte severe da parte dell’ordinamento.
Le famiglie italiane però la pensano diversamente, così come diversamente la pensano su centri d’accoglienza stracolmi collocati in paesi piccoli e piccolissimi e sulle conseguenze poco gradevoli in termini di decoro urbano e qualità della vita che un afflusso indiscriminato di stranieri nullatenenti (inevitabilmente disposti, tra l’altro, a una spietata concorrenza salariale con gli anelli più deboli del mondo del lavoro, per il sollazzo del padronato) può determinare e sta determinando in parecchie città italiane, piccole o grandi che siano. Salvini tutto questo lo sa bene e ci marcia, conscio che l’insistere ossessivamente su questi temi potrebbe procurargli in futuro lusinghieri risultati in termini di consenso elettorale. Non ingannino, da questo punto di vista, i sondaggi che danno la Lega inchiodata al 12- 13 per cento: chi risponde ai sondaggi spesso si vergogna di ammettere che condivide le idee di politici considerati “impresentabili” come il leader leghista. La vicenda di Trump insegna.
La sinistra invece finora si è stoltamente baloccata sulla questione aggrappandosi a quattro narrazioni, per usare un linguaggio caro a Niki Vendola: quella dell’immigrato che ci paga le pensioni e innalza il PIL, immemore che questo genere di immigrato è quello munito di un regolare permesso di soggiorno e il cui ingresso in Italia è da anni ormai impedito dall’emergenza dei barconi; quella dell’accoglienza diffusa, ossia della distribuzione di piccoli nuclei di immigrati in ciascuno degli ottomila comuni della Penisola, immemore che senza una decisa diminuzione degli sbarchi la percentuale di immigrati per comune, oggi fissata in 2,5 unità ogni 1.000 abitanti, nel giro di poco tempo schizzerebbe alle stelle; quella – sublime – della “paura percepita” e sparsa a piene mani tra la popolazione dalla malafede di certi organi di informazione, immemore che basterebbe scendere per una volta dalla ionosfera e interpellare direttamente in strada i cittadini per rendersi conto che di percepito in giro c’è ben poco e, infine, il sempiterno mantra: “è la povertà la madre delle ruberie”, affermazione apodittica che collide clamorosamente con organizzazione, professionalità, personalità, precedenti e tenore di vita di chi oggi è dedito a tempo pieno, ad esempio, al disonesto mestiere di svaligiare le case altrui.
L’esito del referendum, insieme alla sostituzione dell’inquilino del Viminale e alle prese di posizione del commissario europeo all’immigrazione (secondo il quale l’80 per cento dei migranti che arrivano in Italia non sono profughi: una roba che sa tanto di scoperta dell’acqua calda…) paiono tuttavia il segnale di una svolta, anche se non si sa quanto duratura ed efficace. La verità – comunisti o non comunisti- è che forse i vertici del partito democratico a trazione renziana hanno preso atto del peso avuto, nell’esito del disastroso (per il PD) referendum di dicembre, proprio dall’insofferenza di parecchi elettori progressisti verso la filosofia adottata dall’ex premier, un po’ per mentalità (boy scout e cattolico per giunta) e un po’ per calcolo (accoglienza in cambio di condiscendenza comunitaria sui conti italiani), nell’affrontare certe questioni particolarmente scottanti. Da qui il cambio di passo di Minniti : contatti coi Paesi di provenienza per facilitare il rimpatrio degli irregolari, ripristino e aumento dei CIE, con buona pace degli strepiti della sinistra metafisica.
Chi come il sottoscritto, da sinistra e per la salvaguardia della sinistra stessa, questo cambio di passo lo auspicava da tempo non può che esserne soddisfatto, quantunque scettico sulla reale capacità dell’esecutivo di portare a termine la missione, soprattutto per quel che concerne la concreta utilità dei CIE, istituzione che in passato si è sovente rivelata del tutto inutile: nei CIE la permanenza è attualmente limitata per legge, dal punto di vista dei soggetti, a una quota minoritaria di clandestini (i destinatari di espulsioni con accompagnamento coatto alla frontiera) e, dal punto di vista dei tempi, ad appena 3 mesi, alla scadenza dei quali se non s’è individuato il vettore, reperito i documenti o stretto accordi con il Paese d’origine del migrante, allo straniero viene consegnato un foglio di via accompagnato dalla calda raccomandazione di lasciare l’Italia entro tot giorni. Il che equivale a dire “scusate, abbiamo scherzato”.
[1] A onor del vero, l’avversione del vecchio PCI nei confronti del movimento studentesco scaturì più che altro dall’esistenza, in seno ad esso, di un vivace dibattito interno che- quantunque spesso svilito da sloganismo, velleitarismo e furore ideologico- rappresentava comunque, per il monolitico partito di Gramsci e Togliatti, una inammissibile ed eretica deviazione dalla regola aurea del cd. centralismo democratico.