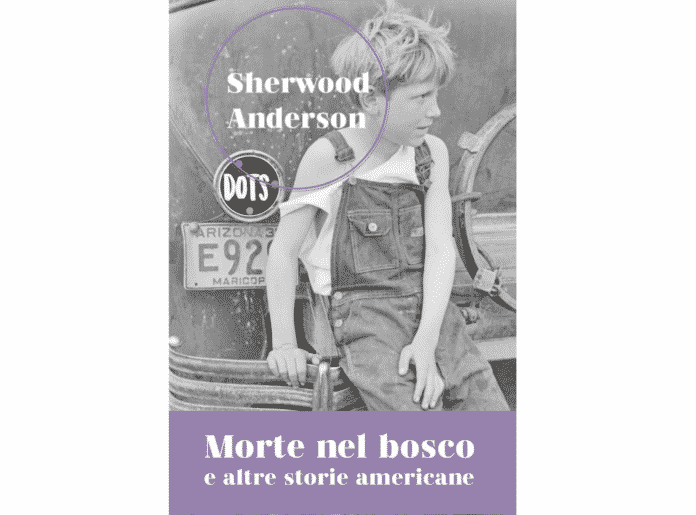Verrà presentato venerdì 27 maggio, alle ore 18.00 alla libreria Feltrinelli di Bari, il libro “Morte nel bosco e altre storie americane” di Sherwood Anderson, pubblicato da DOTS edizioni. Si tratta infatti della prima traduzione italiana, a cura di Flavio Zaurino e Domenico Lonigro, completa di Death in the Woods and Other Stories, opera imprescindibile per gli amanti di Anderson, uno dei maestri della short story statunitense, osannato da personaggi come Bruce Spingsteen, Philip Roth, Nick Cave e Cesare Pavese.
Perché Sherwood Anderson è considerato il padre della letteratura americana?
Flavio Zaurino: In letteratura, ancor più che nei tribunali, le attribuzioni di paternità (o di maternità) si sprecano e sono oggetto di dibattiti particolarmente accesi. Non appena un libro fa il suo ingresso nel mondo, subito ci si affretta a trovargli padri, nonni e antichissimi trisavoli, preferibilmente nobili. Di conseguenza, ogni autore che acquisisca una certa notorietà e dimostri di possedere una voce peculiare e distinta è destinato a essere ritenuto responsabile di una lunga serie di filiazioni più o meno dirette. Ci tocca però sgomberare subito il campo da ogni equivoco: Sherwood Anderson non è il padre della letteratura americana. In primo luogo, egli stesso mai ha ambito a tale posizione, come conferma a più riprese la sua biografia; in secondo luogo, riconoscergli un simile ruolo farebbe torto agli Emerson, Whitman e Thoreau, agli Hawthorne e ai Melville, insomma a tutti gli scrittori che hanno animato quello che il critico Matthiessen ha definito come “rinascimento americano”, quella seconda metà dell’Ottocento nella quale si posero le vere fondamenta della letteratura americana, in un periodo in cui Anderson era poco più che un bambino, essendo nato nel 1876.
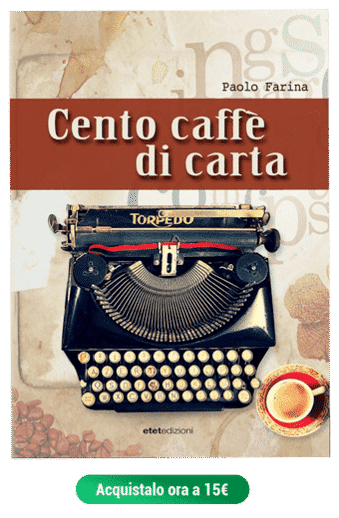
Detto questo, l’equivoco consente sin da subito di far luce sull’autore e sui suoi meriti: Anderson è stato e continua a essere per molti versi un cosiddetto “scrittore per scrittori”, un autore apprezzato probabilmente più dai suoi colleghi che da pubblico e lettori. Una sorte – peraltro non così rara – che nel caso specifico è stata propiziata soprattutto da colui al quale si può serenamente imputare la responsabilità dell’equivoco: William Faulkner.
È stato l’autore di The Sound and the Fury, infatti, a ripetere in più occasioni che senza i libri di Sherwood Anderson non ci sarebbero stati quelli di William Faulkner, di Ernest Hemingway, di Francis Scott Fitzgerald e di tanti altri scrittori. Che, ancora, sarebbe impossibile immaginare la letteratura americana moderna senza gli scritti di Anderson. Si tratta, a ben vedere, di affermazioni tutt’altro che infondate: i testi di storia della letteratura americana certificano una influenza piuttosto netta ed evidente del maturo Anderson sui giovani Faulkner ed Hemingway (pur con esiti alterni, in termini di rapporti personali). Ed è altrettanto vero che Sherwood Anderson ha indubbiamente influenzato il modo di scrivere negli Stati Uniti dei primi tre decenni del Novecento, inaugurando forse per primo la grande stagione modernista. Il nostro autore, d’altra parte, muove i primi passi in un paese che va lasciandosi alle spalle un passato dai tratti insieme idilliaci e selvaggi, che si appresta ad abbracciare con entusiasmo il prorompente industrialismo dal quale nascerà l’America attuale. Da questo mondo in rapida e violenta trasformazione Anderson trae la sostanza di cui sono fatte le sue storie, che consegna alla pagina e ai lettori elaborando una prosa apparentemente semplice, premeditatamente spontanea, ben poco letteraria in senso classico. Una scrittura che, fin dagli esordi, mostra una straordinaria capacità di raccontare la realtà senza ipocrisie e orpelli retorici, e che tuttavia non rinuncia al potere evocativo della parola. Quella di Anderson fu, a suo modo, una piccola rivoluzione e non stupisce dunque che i suoi racconti fossero considerati da alcuni contemporanei addirittura scandalosi, quando non proprio immorali. Nel solco da lui tracciato si mossero poi scrittori destinati a un successo ancora maggiore. Tutti figli di Sherwood Anderson, a loro modo. Figli tanto ingombranti, in alcuni casi, da condannare il padre a un oblio ingiusto.
Da dove deriva lo stile unico, sottile e ironico delle short stories di Anderson?
Domenico Lonigro: T.S. Eliot, nello celebre saggio Tradition and the Individual Talent, definisce la mente dell’artista in termini piuttosto efficaci: quelli di un deposito. Un grande magazzino nel quale l’artista – sia egli un poeta, un romanziere, un pittore… – accumula sensazioni, immagini, frasi o anche semplici grumi di parole che lì rimangono fino al punto in cui – così ancora Eliot – tutti gli elementi utili a formare un nuovo prodotto d’arte non sono finalmente presenti.
Ecco, poste queste premesse, bisogna innanzitutto dire che nei racconti di Anderson confluiscono tutti gli elementi – antropici e più latamente umani, in primo luogo, ma poi anche sociali, ambientali e paesaggistici – di una America preindustriale ormai al tramonto. D’altro canto risulta difficile, se non impossibile, rintracciare un’origine unica per quello che viene comunemente definito lo “stile” di uno scrittore, e di Anderson in particolare. Sarebbe forse più funzionale parlare di “scrittura” tout court: di una voce, per usare un altro termine abusato che purtuttavia possiede forse maggior diritto di cittadinanza nel caso delle opere di Anderson.
Perché se ogni scrittore che meriti tale definizione ha un proprio stile, una propria scrittura, una propria voce dunque, quella di Sherwood Anderson a maggior ragione si differenzia e si fa riconoscibilissima nel momento in cui la lettura dei racconti deve fare i conti col tono di pacata confidenza, con un umorismo tenue e sommesso, con una garbata reticenza che, mentre guarda all’intimità dei personaggi, lo fa sempre con estrema delicatezza.
Se, infine, vogliamo parlare in senso stretto di ironia, o meglio ancora di humour, possiamo senz’altro dire che leggendo i racconti di Anderson – in specie quelli che raccontano la vita interiore di personaggi difformi e irregolari calati in un universo governato da leggi spesso impenetrabili – si ha l’impressione che l’autore avesse compreso appieno che la differenza tra il lato cosmico delle cose e il loro lato comico dipende da soltanto una sibilante. E qui parafrasiamo quel che Nabokov scriveva a proposito di Gogol, uno scrittore al quale Anderson è stato accostato in più di un’occasione.
Qual è il principale elemento che si rischia di perdere nella traduzione di Morte nel bosco e altre storie americane?
F: Una massima celebre nel settore degli studi sulla traduzione afferma che “ogni traduzione è un tradimento”. Al di là dell’indubbia efficacia del gioco di parole, la frase possiede un insindacabile fondo di verità. Tradurre è tradire, senza ombra di dubbio, e nondimeno la nostra traduzione di Morte nel bosco e altre storie americane è stata guidata dalla volontà di rispettare fino in fondo e nella massima misura possibile le intenzioni originarie dell’autore. Dopo questa bella dichiarazione d’intenti, tuttavia, dobbiamo già fare parziale ammenda: il titolo originale della raccolta è infatti un altro. Quando fu pubblicata per la prima volta, nel 1933, l’opera si intitolava Death in the Woods and Other Stories: il tradimento, seppur minimo, c’è stato anche questa volta, ma possiamo spiegare tutto. Preferire l’aggettivo “americane” ad “altre” non è stato altro che una logica conseguenza: dei sedici racconti che compongono la raccolta, quindici sono di ambientazione americana e tutti, in misura maggiore o minore, manifestano evidenti legami col sostrato sociale, paesaggistico e culturale degli Stati Uniti di quegli anni. Anni tipicamente “americani”, poi, nell’immaginario europeo: parliamo di un periodo che spazia dai primi decenni del Novecento alla fine del Proibizionismo, un’epoca in cui gli U.S.A. si configurano come potenza mondiale, iniziando a porre le basi della successiva egemonia culturale, destinata a vacillare solo dopo la guerra in Vietnam.
Se invece vogliamo parlare di un singolo elemento che rischia di andare smarrito nella traduzione in italiano – e sulla salvaguardia di questo elemento si sono concentrati tutti i nostri sforzi – non possiamo non fare riferimento al tono di Anderson: a quella voce sommessa e ironica di cui dicevamo in precedenza, che sulla pagina si traduce in una certa reticenza di fondo sempre pronta ad affiorare, in uno sguardo compassionevole ma mai pietoso, in un senso dell’umano che costituisce a nostro avviso il nucleo fondante della sua narrativa. La necessità di preservare simili, inconfondibili qualità ha richiesto peraltro una delicatissima operazione di calibratura resa particolarmente ardua dall’ampia varietà di registri che Anderson si dimostra capace di toccare, specie in una raccolta particolarmente eterogenea qual è quella da noi tradotta.
Probabilmente, a muoverci più d’ogni altra considerazione nel nostro lavoro, è stato questo obiettivo: dare anche ai lettori italiani la possibilità di leggere i racconti di uno scrittore che dà prova di una sensibilità e di un’ampiezza espressiva non comuni.
Il fil rouge che unisce i sedici racconti tende a colpevolizzare o a essere indulgenti con vizi e virtù degli esseri umani?
D: Come dicevamo, a tenere insieme i sedici racconti è senz’altro la qualità della scrittura: si è parlato a tal proposito di stile, di voce, di sguardo. Sono termini che si equivalgono, in una certa misura e fino a un certo punto, fatte le opportune distinzioni che non a caso sono state poste in premessa.
L’autentico collante dell’opera è rappresentato dalla figura dell’autore/narratore: quella di Sherwood Anderson in Morte nel bosco e altre storie americane è una presenza costante ma mai ingombrante. L’autore non travalica mai i confini della pagina pur essendo sempre o quasi sempre presente e ben riconoscibile, tanto che non sarebbe fuorviante parlare – per noi che l’abbiamo tradotto, certo, ma anche per i lettori – di un dialogo sempre possibile: tutto quel che c’è da fare è prestare ascolto, fare attenzione ai dettagli di cui si compone la scrittura di ogni racconto. Così facendo, oltre a narrazioni sempre godibili e a personaggi estremamente realistici, si entra in un rapporto attivo, quasi confidenziale, con l’autore e con le sue creature. È forse per questo che autori del pieno modernismo, come i già citati Faulkner e Fitzgerald, lo hanno riconosciuto come “padre”.
Un padre, Sherwood Anderson, dimostra tuttavia di esserlo soprattutto verso i suoi personaggi, quelli che altrove definisce i suoi “grotteschi”: donne e uomini osservati da vicino, sempre con delicato umorismo ed elegante compassione. Lo scopo di Anderson, d’altro canto, non è mai quello di esprimere espliciti giudizi morali; si dimostra anzi uno scrittore ben poco incline a separare nettamente vizio e virtù, bontà e cattiveria. Quel che più conta per lui è catturare e restituire al lettore le centinaia e centinaia di verità – tutte meravigliose e degne di essere raccontate – che ogni singolo essere umano porta con sé. Un autore simile, tanto curioso nei confronti dell’umanità, tanto pronto a indagarne le luci e le ombre senza mai distogliere lo sguardo, non può che invitare alla comprensione e, non da ultimo, alla presa di coscienza del destino ultimo che accomuna tutti gli esseri umani.
Consigliereste ai giovani la lettura di Sherwood Anderson?
F: Questa domanda da un lato ci coglie di sorpresa, dall’altro ci offre una possibilità.
La sorpresa nasce dal fatto di non aver mai pensato all’autore, e all’opera che abbiamo tradotto in particolare, come a un autore e a un’opera destinati a uno specifico pubblico di lettori. Certo, il titolo si pone fin da subito a un estremo dell’umana esistenza, prefigurando un evento tradizionalmente associato a età ben più avanzate di quella giovanile. Tuttavia, ecco che sorge la possibilità di identificare un punto di forza dell’opera nell’assoluta eterogeneità che la caratterizza. Morte nel bosco e altre storie americane è una raccolta di testi estremamente vari per personaggi, tematiche e suggestioni: se la morte domina indubbiamente, oltre al titolo dell’opera, anche quelli del primo e dell’ultimo racconto e le relative vicende rappresentate, la vita è invece celebrata in testi come L’inondazione o Un viaggio sentimentale. Vi sono racconti in cui centrale è la figura femminile – Come una regina, su tutti, ma anche Una donna raffinata, Un’altra moglie ed Eccola lì! Si fa il bagno, lei! – e altri in cui il fuoco della narrazione è al maschile: Il ritorno, La lotta, Un viaggio sentimentale. Non mancano poi né l’azione – La parola alla giuria offre in tal senso spunti che oseremmo definire cinematografici – né atmosfere più meditative, raggiunte anche grazie a un sapiente impiego delle descrizioni, come in Questi montanari.
Insomma, una raccolta così complessa e articolata, che rappresenta l’ultima opera dell’autore e per questo forse la più completa e senz’altro la più matura, probabilmente andrebbe letta a ogni età.

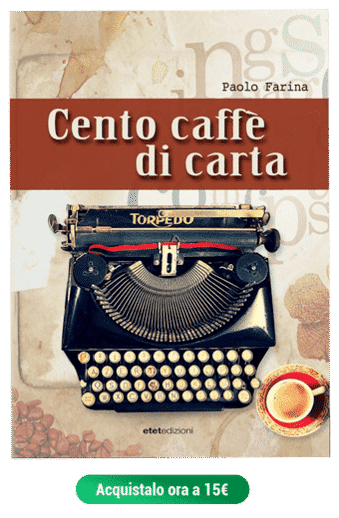




 L’iniziativa si sviluppa parallelamente all’apertura dei nuovi uffici di Bari di NTT Data Italia e si inserisce nel vasto programma di investimenti previsti dall’azienda, con l’obiettivo di far diventare il capoluogo pugliese un polo innovativo all’interno del gruppo giapponese, favorendo al contempo la creazione di nuovi posti di lavoro (fino a 150 assunzioni nel primo anno).
L’iniziativa si sviluppa parallelamente all’apertura dei nuovi uffici di Bari di NTT Data Italia e si inserisce nel vasto programma di investimenti previsti dall’azienda, con l’obiettivo di far diventare il capoluogo pugliese un polo innovativo all’interno del gruppo giapponese, favorendo al contempo la creazione di nuovi posti di lavoro (fino a 150 assunzioni nel primo anno).