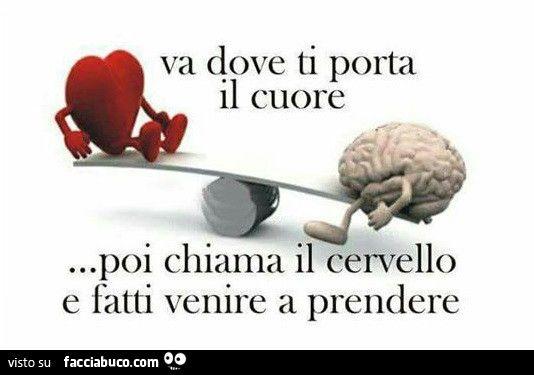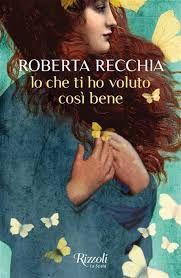Ho appena finito la seconda stagione della Famiglia Addams su Netflix. Sì, è mainstream. Sì, è “da adolescenti”.
E sì, mi ci sono persa con gioia.
C’è qualcosa di profondamente liberatorio nel lasciarsi andare a ciò che ci piace, senza doverlo giustificare.
Mercoledì mi ha rapita con il suo mondo gotico, ironico e profondo. Una protagonista che non chiede il permesso per essere se stessa, che cammina fuori dal coro con passo deciso. E io, da spettatrice, mi ci sono ritrovata.
Ora voglio solo scoprire il seguito, il continuum, quel filo nero che lega i cuori eccentrici e ribelli.
Perché non è l’etichetta a definire il valore di una storia, ma il modo in cui ci parla.Nel mio flusso di passioni ci sono anche due nuove uscite che ho preso al volo:
"Missione Amore"
di Taverna una storia dolce e leggera, con Chico, un Maltipoo adorabile che ti ruba il cuore. Un libro che profuma di tenerezza e semplicità, perfetto per chi ama le coccole narrative.
"L’ultimo segreto "di Dan Brown — dopo più di dieci anni, Langdon torna in corsa. Un thriller che intreccia neuroscienze, spiritualità e misteri antichi. Ambientato tra Praga e archivi segreti, è una corsa contro il tempo che non delude chi ama il brivido intellettuale.Che siano serie, romanzi, storie leggere o trame dense di simbolismo…
Se mi parlano, le ascolto.
Se mi emozionano, le seguo.
Se mi somigliano, le abbraccio.Essere fedeli a se stessi è il vero atto di ribellione.
E io, nel mio piccolo, continuo a farlo. Sempre.
E mentre Langdon corre e Mercoledì scruta, metto Allegria di Ornella Vanoni in sottofondo.
Perché anche i cuori eccentrici hanno bisogno di luce.